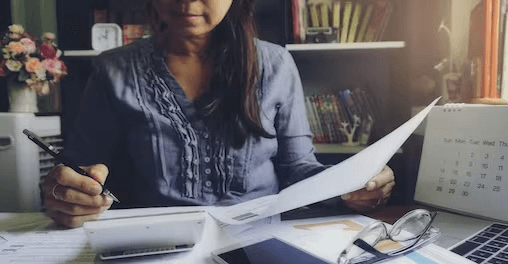LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA
Cass. Sez. Lav., 14 luglio 2023, n. 20239
Pres. Raimondi; Rel. Pagetta; P.M. Filippi; Ricorrente: V.M.; Resistente: C.I. S.p.A.
Patto di prova – Mancata specificazione delle concrete mansioni e dell’indicazione del profilo professionale attribuito – Nullita’ del patto – Recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova – Illegittimità – Tutela applicabile – Art. 3, comma 1, d. lgs. n.23 del 2015 – Tutela indennitaria – Applicazione – Reintegra – Esclusione – Ratio
Anche nel vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 – che non ha modificato sotto il profilo sostanziale l’assetto della legge n. 604 del 1966 in punto di necessaria causalità del recesso datoriale – il recesso ad nutum intimato in assenza di un valido patto di prova non è radicalmente nullo per assenza del relativo potere in capo al datore di lavoro ma è un licenziamento intimato per ragioni che non sono riconducibili ad alcuna di quelle in presenza delle quali la l. n. 604 del 1966 consente al datore di lavoro la unilaterale risoluzione del rapporto con applicazione della tutela indennitaria ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/15 che disciplina le ipotesi di licenziamento intimato in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo. La nullità della clausola appositiva del patto di prova, in quanto parziale, non si estende dunque all’intero contratto ma determina la conversione del rapporto in prova in rapporto ordinario con applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, del regime ordinario del licenziamento individuale.
NOTA
La Corte di appello di Milano, respingendo l’appello di una lavoratrice, licenziata durante il periodo di prova, ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti, aveva dichiarato l’estinzione del rapporto di lavoro per effetto del recesso datoriale motivato con il mancato superamento del periodo di prova e condannato la società datrice di lavoro a corrispondere alla lavoratrice, ai sensi dell’art. 3, comma, 1 d.lgs. n. 23 del 2015, un’indennità corrispondente a quattro mensilità della retribuzione. La Corte distrettuale ha condiviso la valutazione di prime cure in punto di nullità del patto di prova e ha escluso l’esistenza di un motivo illecito determinante il licenziamento; ha poi ritenuto che le conseguenze dell’illegittimo recesso datoriale intimato sulla base di un patto di prova nullo non fossero riconducibili alla fattispecie regolata dal comma 2 dell’art. 3 d. lgs. n. 23 del 2015, implicante l’applicazione della tutela reale, ma regolate dal comma 1 dell’art. 3 d. lgs. cit., con applicazione, quindi, della sola tutela indennitaria.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la lavoratrice lamentando, tra il resto, la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d. lgs. n. 23 del 2015 o, in subordine, dell’art. 1418 cod. civ., in quanto, in carenza di un valido ed efficace patto di prova, il licenziamento intimato per mancato superamento della stessa è nullo, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., per contrasto con l’art. 1 della legge n. 604 del 1966, norma imperativa posta a tutela di interessi rilevanti ai sensi degli artt. 1, 4, 35, 36, 41, comma 2, Cost». La lavoratrice ha sostenuto in particolare «la “totale carenza” di potere in capo alla parte recedente per essere il licenziamento stato intimato al di fuori delle causali tipizzate dalla legge, collocandosi, quindi, all’esterno del perimetro nell’ambito del quale l’ordinamento consente l’esplicazione del potere datoriale di recesso; osserva che sul piano delle tutele applicabili, la configurazione come nullo del recesso datoriale comportava l’applicazione della tutela reintegratoria piena ex art. 2, comma 1, d. lgs. n. 23 del 2015, o, in subordine, della tutela di diritto comune – ripristino del rapporto e risarcimento del danno».
La Corte ha respinto il ricorso ricordando la giurisprudenza consolidata secondo la quale: «la nullità della clausola che contiene il patto di prova, in quanto parziale, non si estende all’intero contratto ma determina la automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio, in conformità del meccanismo prefigurato dall’art. 1419, comma 2 cod. civ.». Sul piano delle conseguenze connesse al licenziamento ad nutum intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo, è stato chiarito che «la trasformazione dell’assunzione in definitiva comporta il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall’art. 1 l. n. 604 del 1966; in presenza di un patto di prova invalido, la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla relativa disciplina limitativa dettata dalla legge n. 604 del 1966; il recesso del datore di lavoro equivale, quindi, ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo. Per costante enunciato del giudice di legittimità, infatti, il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull’erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadenza), si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato – ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto – dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità e soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato motivo».
Pertanto, nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, il potere esercitato dal datore di lavoro non risulta radicalmente insussistente come, viceversa, sostenuto dalla parte ricorrente, ma è soggetto alle limitazioni connesse al principio di causalità e tipicità del licenziamento, non venendo in rilievo l’an ma solo il quomodo del relativo esercizio. Ritiene, infine, il Collegio che «il recesso ad nutum in oggetto, intimato in assenza di valido patto di prova, non riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 3 d. lgs n. 23 del 2015 nelle quali è prevista la reintegrazione, resta assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria».
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Cass. Sez. Lav., 14 luglio 2023, n. 20215
Pres. Raimondi; Rel. Ponterio; P.M. Sanlorenzo; Ric. A. M. A.; Controric. C. C. S.r.l.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Elementi costitutivi – Obbligo di repêchage – Offerta di reimpiego in mansioni di livello inferiore – Rifiuto del dipendente – Prova da parte del datore – Necessità – Effettivo svolgimento di mansioni di livello inferiore al momento del recesso – Rilevanza – Impossibilità sopravvenuta della prestazione – Insussistenza – Fattispecie: impossibilità di adibizione alla mansione di strumentista di sala operatoria perché non in possesso del prescritto titolo di studio
La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l’esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall’altro, l’impossibilità di collocazione del lavoratore in una posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti oppure l’impossibilità di collocamento in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, il cui onere di allegazione e dimostrazione incombe sul datore di lavoro. In tale contesto, l’effettivo reimpiego del lavoratore, al momento del recesso, in mansioni – di livello inferiore e comunque – diverse da quelle originariamente espletate, è espressione del repêchage attuato dal datore di lavoro e della non attualità dell’esigenza organizzativa posta a base del recesso, restando del tutto irrilevante – e, in particolare, non configurando un’ipotesi di rifiuto o impossibilità della prestazione – la mera contestazione del lavoratore in merito all’assegnazione a tali mansioni.
NOTA
Nel caso di specie la datrice di lavoro comunicava ad una dipendente l’impossibilità di continuare ad adibirla alle mansioni di strumentista di sala operatoria, sino ad allora espletate, poiché priva del necessario titolo di studio. La dipendente impugnava il provvedimento con ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo il ripristino delle originarie mansioni. In attesa del provvedimento giudiziale, la società assegnava la dipendente allo svolgimento delle diverse e inferiori mansioni di addetta all’ufficio amministrativo. La dipendente contestava e impugnava con ricorso ex art. 700 c.p.c. anche tale ultimo provvedimento. Successivamente, la società comunicava alla lavoratrice il licenziamento sul rilievo della presunta impossibilità di adibirla alle mansioni per cui era stata assunta e neppure ad altre coerenti con la sua qualificazione professionale.
A fronte di ciò, la lavoratrice impugnava in giudizio il licenziamento.
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello rigettava le pretese della lavoratrice, ritenendo accertata l’inesistenza di mansioni confacenti alla sua qualifica professionale nonché il rifiuto della dipendente allo svolgimento delle mansioni di addetta all’ufficio amministrativo e, quindi, integrato un giustificato motivo di recesso ex art. 1464 c.c., per il venir meno di un apprezzabile interesse datoriale all’adempimento della prestazione lavorativa.
Per l’annullamento di tale decisione, proponeva ricorso alla Suprema Corte la dipendente, lamentandone l’erroneità per avere la Corte d’appello giudicato legittimo il licenziamento, sul presupposto della sopravvenuta impossibilità di adibire la dipendente alle mansioni di strumentista di sala, sebbene tali mansioni non fossero più attuali alla data del recesso in quanto la predetta svolgeva, a tale data, le nuove mansioni di addetta all’ufficio amministrativo.
A fronte di tali censure, la Cassazione ha accolto il ricorso, pronunciandosi come da massima. In particolare, la Corte ha ritenuto errata la sentenza d’appello poiché ha ritenuto esistente il rifiuto e/o l’impossibilità della dipendente di svolgere le mansioni di addetta all’ufficio amministrativo alla medesima assegnate senza considerare il dato fattuale – di «valenza decisiva» – dello svolgimento effettivo delle stesse sino alla data del licenziamento. Secondo la Corte, inoltre, è irrilevante in tale ottica la mera contestazione da parte della lavoratrice del provvedimento datoriale di assegnazione alle nuove e diverse mansioni, che si colloca «su un piano diverso dal rifiuto e/o impossibilità di eseguire la prestazione in quanto attiene all’esercizio del diritto alla professionalità» e «non è equiparabile e neppure confondibile con l’omesso svolgimento della prestazione» disciplinarmente rilevante.
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
Cass. Sez. Lav. 18 luglio 2023, n. 20882
Pres. Raimondi; Rel. Cinque; P.M. Mucci; Ric. A.D.M.; Controric. F.D.C. S.p.A.
Licenziamento per giusta causa – Dirigente – Vincolo fiduciario – Sussistenza – Ratio – Dirigente che si presta ad accordo con AD e vicepresidenti volto a rimuovere il presidente della società – Legittimità
Il rapporto di lavoro con un dirigente è caratterizzato dall’elemento fiduciario che lo lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o un’importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso e, a tal fine, è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.
NOTA
La Corte d’Appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro, di cui “era dirigente con mansioni di Direttore del Controllo di Gestione e Chief Financial Officier (C.F.O.)”, volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 12 dicembre 2019 per i fatti descritti nella lettera di contestazione disciplinare dell’11 ottobre 2019, “con cui gli erano stati attribuiti sei distinti addebiti relativi alla condotta di avere partecipato attivamente, insieme all’amministratore delegato e a due vice presidenti, ad un disegno occulto teso a rimuovere dalla carica il Presidente della società Cav. F.A.D.C.”.
La Corte d’Appello riteneva, infatti, che “a) la acquisizione degli elementi (conversazioni di cui sopra) nell’ambito del procedimento penale era rituale essendo avvenuta all’esito dell’accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 cpc in cui anche il difensore della parte offesa aveva diritto a partecipare, ad esaminare l’esito e ad estrarne copia; b) non era ravvisabile alcuna violazione dell’art. 4 legge n. 300/70 vertendosi in una ipotesi di un controllo del tutto estraneo all’esecuzione della prestazione lavorativa; c) né si poteva ipotizzare un illegittimo controllo difensivo su una cartella di posta elettronica in uso al lavoratore licenziato sia perché molte delle conversazioni estratte erano avvenute su chat private e/o su indirizzi di posta personale dei soggetti interessati, sia perché gli accounts e le utenze da cui era avvenuta l’estrazione appartenevano ad un terzo (F.F.); d) il controllo effettuato non era anteriore al sospetto perché l’acquisizione di tali dati non era avvenuta per effetto di controlli difensivi disposti ex art. 4 legge n. 300 del 1970, bensì attraverso la estrazione di dati del consulente della Procura della Repubblica di apparecchi e/o supporti informatici in uso a F.F.; e) conseguentemente non era invocabile, proprio per le modalità di acquisizione dei dati, alcuna inosservanza del Regolamento generale per la protezione dei dati personali; f) nessuna contestazione sostanziale sul contenuto dell’incolpazione era stata formulata; g) la contestazione degli addebiti, avvenuta l’11.10.2019, a fronte della conoscenza dei datti estratti (26.9.2019) era da considerarsi tempestiva; h) non vi era stato alcun malgoverno delle richieste istruttorie, avanzate dal D.M., da parte del primo giudice; i) erano stati dimostrati i fatti che avevano condotto al licenziamento ad nutum del Dirigente, sussistendo una giusta causa di recesso, in quanto era ravvisabile la violazione palese dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro”.
Il lavoratore impugnava la sentenza di secondo grado.
La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo immune da vizi l’iter argomentativo della Corte territoriale, che riteneva “la condotta contestata –riguardante la partecipazione attiva (attraverso la messa a disposizione delle informazioni in suo possesso quale Direttore del Controllo di Gestione e di Chief Financial Officer) del D.M. al tentativo ordito dall’amministratore F.F. e dai Vicepresidenti, teso a sovvertire la governance della società (nonché al licenziamento dei dipendenti fedeli al Presidente Cav. F.A.D. C.)– fosse appunto lesiva della fiducia in lui riposta”.
La Corte di Cassazione precisa, infatti, che “in tema di licenziamento disciplinare del dirigente ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si identifica con la giusta causa. Ne deriva che, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente”.
In sostanza, la Corte Suprema conferma la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore/dirigente che mette a disposizione dell’amministratore e dei vice presidenti – autori di un disegno teso a sovvertire la governance della datrice di lavoro – le informazioni in suo possesso in ragione del ruolo ricoperto di CFO.
NOZIONE DI MOBBING
Cass., Sez. Lav., ord. 20 luglio 2023, n. 21682
Pres. Esposito; Rel. Michelini; Ric. Omissis; Contr. Omissis
Mobbing – Art. 2087 c.c. – Responsabilità oggettiva – Esclusione – Danno alla salute – Onere della prova a carico del lavoratore – Esistenza del danno – Nocività dell’ambiente – Nesso causale – Esperimento – Onere della prova a carico del datore di lavoro – Aver adottato le misure necessarie
L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
NOTA
La Corte di appello di Bologna, a conferma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale del medesimo luogo, rigettava le domande, aventi ad oggetto l’accertamento della sussistenza di condotte mobbizzanti e la conseguenziale condanna al risarcimento del danno patrimoniale, biologico, esistenziale e morale, proposte da un lavoratore nei confronti della società ex datrice di lavoro.
La Corte territoriale, all’esito dell’istruttoria e sulla base delle risultanze acquisite dal Tribunale, concludeva che il dipendente non aveva assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante relativamente all’esistenza di comportamenti vessatori o intimidatori, ripetuti e costanti, da parte del datore di lavoro.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte si sofferma sull’articolazione dei rispettivi oneri di allegazione e di prova in materia di risarcimento del danno da mobbing, osservando che «il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l’attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, con modalità congrue e tollerabili;».
Dunque, solo ove il lavoratore dimostri l’esistenza del danno alla salute, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso eziologico tra l’uno e l’altro, il datore di lavoro avrà l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c..
Ed invero, afferma la Corte di Cassazione anche richiamando precedenti giurisprudenziali, «l’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva..» ma di responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici, «né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo…».
La Corte di Cassazione ritiene pertanto immune da vizi l’iter argomentativo della Corte territoriale e rigetta il ricorso con condanna alle spese del lavoratore.
Fonte: Il Sole 24Ore